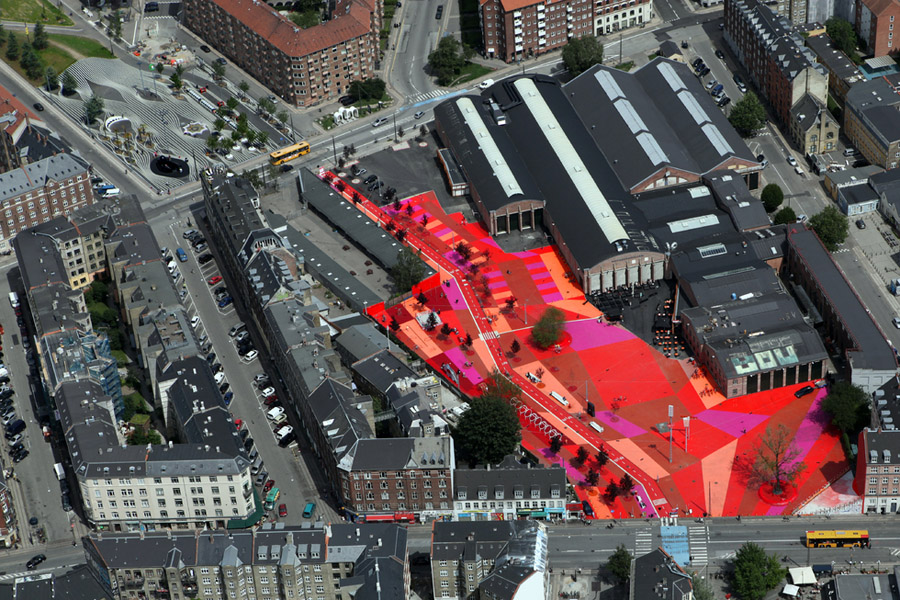di Elena Tebano
di Elena Tebano
dal Corriere della Sera del 20/7/13
Nel dibattito infinito su libertà sessuali, emancipazione della donna e conciliazione tra lavoro e famiglia, è un tassello nuovo. Per qualcuno, come la giornalista Hanna Rosin (autrice di La fine del maschio e l’ascesa delle donne, Cavallo di ferro, 2013) è anche un passo avanti, una strategia adeguata ai tempi che permette alle giovani donne di fare carriera e intanto avere una vita sessuale soddisfacente. Altri lo hanno criticato come il risultato di un femminismo «estremo», che le ha convinte di non aver bisogno di un uomo proprio nel periodo migliore per trovare il loro futuro marito, «l’architrave della felicità» da adulte. Come al solito, è un’alternativa troppo stretta per le donne.
Prima il dovere, poi il piacere
Dall’inchiesta del Times non emerge neppure il fantasma della «vita sessuale soddisfacente» di cui parla Rosin. Molti lettori, nei commenti, hanno messo in evidenza come le ragazze raccontano di aver bisogno di bere, per i loro incontri «senza impegno»: una mancanza di lucidità che a volte rende molto labili i confini tra sesso consensuale e non. E solleva dubbi inquietanti sulla loro effettiva capacità di scegliere. Le parole delle universitarie americane non hanno niente della retorica, forse un po’ ingenua ma senz’altro gioiosa, che la rivoluzione sessuale degli anni ’70 aveva associato ai rapporti occasionali.
Dall’inchiesta del Times non emerge neppure il fantasma della «vita sessuale soddisfacente» di cui parla Rosin. Molti lettori, nei commenti, hanno messo in evidenza come le ragazze raccontano di aver bisogno di bere, per i loro incontri «senza impegno»: una mancanza di lucidità che a volte rende molto labili i confini tra sesso consensuale e non. E solleva dubbi inquietanti sulla loro effettiva capacità di scegliere. Le parole delle universitarie americane non hanno niente della retorica, forse un po’ ingenua ma senz’altro gioiosa, che la rivoluzione sessuale degli anni ’70 aveva associato ai rapporti occasionali.
«Mi sono “posizionata” nel college in modo da non poter avere relazioni romantiche significative, perché sono sempre impegnata. E le persone che mi interessano sono sempre impegnate», racconta «A.», una delle intervistate. «Se sono sobria, lavoro», aggiunge.
Il sesso per queste giovani non sembra né un modo per divertirsi, né per capire qualcosa di sé o degli altri. Il linguaggio è quello del marketing: costo, benefici, investimenti. Tutto è subordinato alla carriera, tutto è prestazione: i risultati economici invadono ogni relazione personale. Per il piacere rimangono solo brevi intervalli ebbri.
Grandi possibilità, maggiori pressioni
Più che il frutto di un femminismo estremo, la vita sessuale delle studentesse d’élite americane sembra condizionata da una società sempre più competitiva e schiacciata dalla crisi economica. Che ha anticipato e reso più duro il dilemma delle donne ambiziose: rassegnarsi a indispensabili sacrifici o provare ad avere tutto? (Il limite più grande di questa domanda è che continuano a farsela quasi soltanto le donne).
Più che il frutto di un femminismo estremo, la vita sessuale delle studentesse d’élite americane sembra condizionata da una società sempre più competitiva e schiacciata dalla crisi economica. Che ha anticipato e reso più duro il dilemma delle donne ambiziose: rassegnarsi a indispensabili sacrifici o provare ad avere tutto? (Il limite più grande di questa domanda è che continuano a farsela quasi soltanto le donne).
È un fenomeno che riguarda soprattutto le giovani delle classi sociali più alte, o candidate a farne parte. E con le dovute differenze, riguarda anche le italiane. «Oggi è difficile rimanere in un posto fisso, soprattutto per i lavori molto qualificati: metto nel conto di poter andare via dall’Italia. So che sarebbe difficile mantenere delle relazioni a distanza. E quindi non mi ci metto neanche», dice Sara (che ha chiesto di non comparire con il suo vero nome), 22 anni, al quarto anno di università alla Bocconi di Milano. «Ho fatto tutta la triennale fidanzata. Adesso sono contenta di non esserlo: mi sentirei limitata, non partirei per il periodo di scambio all’estero con la stessa tranquillità», afferma Chiara, al primo anno della specialistica, sempre in Bocconi.
Forse alla base di questa paura c’è anche una concezione dei rapporti tutt’altro che moderna. «Ho passato un sacco di tempo a incoraggiare il mio ex, che era indietro con gli esami; a pianificare il suo studio invece del mio. Noi donne siamo comunque propense a mettere l’uomo davanti a noi stesse. Ma ora ho capito che sbagliavo», aggiunge. Non tutte la pensano così: «Si può trovare il tempo per lo studio, per gli amici e per il fidanzato», dice Giulia, 21 anni, anche lei studentessa della Bocconi, che infatti ha una storia da un anno. «È pieno di donne che hanno le loro carriere senza rinunciare alla famiglia. Forse tutto tutto non lo puoi avere, ma almeno ci puoi provare», garantisce. Eppure molte sue coetanee preferiscono la strada più facile dei rapporti poco impegnativi.
«Facevo come un maschio»
Eleonora, 25 anni, laureanda alla Luiss di Roma, è una delle giovani che hanno scelto il sesso senza legami emotivi (il nome è di fantasia). «L’anno scorso ho conosciuto un ragazzo e ho pensato di aver avuto un colpo di fulmine. Poi ci ho parlato e mi sono resa conto che non avrei mai voluto una storia con lui». Per lei era solo attrazione fisica.
Eleonora, 25 anni, laureanda alla Luiss di Roma, è una delle giovani che hanno scelto il sesso senza legami emotivi (il nome è di fantasia). «L’anno scorso ho conosciuto un ragazzo e ho pensato di aver avuto un colpo di fulmine. Poi ci ho parlato e mi sono resa conto che non avrei mai voluto una storia con lui». Per lei era solo attrazione fisica.
«Sapevamo che quando uscivamo poi finivamo a letto. Ma a me il pre-serata non interessava. Volevo solo bermi un bicchiere di vino, fumarmi una canna e fare sesso. Staccare. Una volta mi venne a prendere e gli dissi subito: “Sali”. Reagì molto male. Alla fine ha sviluppato una considerazione negativa di me, perché mi comportavo come un ragazzo».
La cosa più irritante per Margherita Ferrari, scrittrice di 25 anni che ha fondato Soft Revolution, («un magazine femminista sul web» gestito da ventenni), è proprio questo doppio standard. «Oggi le mie coetanee si sentono più tranquille di un tempo ad avere relazioni senza legami affettivi. Ma per questo vengono ancora stigmatizzate, al contrario dei ragazzi. L’ho visto succedere alla Columbia University di New York, dove ho studiato sei mesi. E anche in Italia», dice.
Eppure non sembra solo questione di aspettative di genere. Molte giovani descrivono una società in cui la pressione sociale verso il successo brucia tutto il resto. Soprattutto per le donne, che nel mondo del lavoro devono ancora affrontare più ostacoli rispetto ai colleghi maschi. «I primi anni di università avevo un ragazzo: mi sono pentita di tutto il tempo che gli ho dedicato. Se una relazione non dura non ne vale la pena. E le cose non durano. Per questo ho cercato una maggiore leggerezza — ragiona Eleonora —. Anche perché siamo bombardati da messaggi che fanno sembrare tutto facile. Ma raggiungere i propri obiettivi non è facile. Allora cerco almeno di limitare i danni dove posso. Forse così elimino una delle esperienze più belle, l’amore, ma ci sarà tempo più in là. È un atteggiamento comune», assicura. Se questa generazione è estremamente consapevole del lavoro necessario a costruire una carriera di successo, sembra stranamente ignara di quanto ne serva per imparare a vivere relazioni, affetti ed emotività. Il rischio è scoprire troppo tardi che, se non si inizia a vent’anni, recuperare dopo è difficile.
allora, dirò che questo scenario mi fa orrore.
senza mezzi termini orrore.
le donne come i maschi, che idiozia.
che lutto, che perdita, che non senso.
stigmatizzazione? involuzione e impoverimento della femminilità e del suo enorme potenziale affettivo creativo rivoluzionario.
stigmatizzazione? involuzione e impoverimento della femminilità e del suo enorme potenziale affettivo creativo rivoluzionario.
è un invito alla fine della specie umana, e così sia.
le donne sono impazzite e faranno saltare tutto il sistema solare.
poi a 50 anni si domandano come mai non rimangono incinta e invocano la scienza per andare incontro a deliri di onnipotenza procreativa.
e poi piangono solitudine o peggio ancora, inveiscono aggressive con i canini di fuori, contro i maschi sciovinisti ed egoisti, dopo aver massacrato tutto l'immaginario-ancora talvolta sano -maschile sulle donne e la femminilità.
ripenso alla strepitosa Virginia Woolf che vaticinava, nella sua stanza tutta per sè, che:
È meglio fare lo scaricatore di carbone o la bambinaia? La donna delle pulizie che ha cresciuto otto bambini ha meno valore per il mondo dell'avvocato che ha accumulato centomila sterline? È inutile farsi queste domande; tanto nessuno sa dare una risposta. Non solo il valore relativo di domestiche e avvocati aumenta e diminuisce di decade in decade, ma non possediamo alcuna unità di misura con cui valutarlo, neanche in questo momento. Anche se si potesse stabilire il valore attuale di una capacità qualsiasi, quegli stessi valori cambieranno; molto probabilmente fra un secolo saranno mutati del tutto. Inoltre, tra cento anni, pensai, giunta alla porta di casa, le donne avranno smesso di essere il sesso protetto. È logico pensare che prenderanno parte a tutte quelle attività e quelle mansioni che un tempo erano loro precluse. La bambinaia scaricherà il carbone. La bottegaia guiderà una macchina. Tutte le supposizioni fondate sui fatti osservati quando le donne erano il sesso protetto saranno crollate, come, per esempio, (qui un drappello di soldati passò per la strada) l'idea che donne, sacerdoti e giardinieri vivano più a lungo degli altri. Eliminate quella protezione, esponetele agli stessi sforzi e alle stesse attività, fatele soldati, marinai, macchinisti e scaricatori di porto, e non moriranno le donne tanto più giovani e più velocemente rispetto agli uomini, che si dirà: "Ho visto una donna oggi", come prima si diceva: "Ho visto un aereo"? Tutto potrà accadere quando l'essere donna avrà smesso di essere un'occupazione protetta, pensai, aprendo la porta.
Datele altri cento anni, datele una stanza tutta per sé e cinquecento all'anno, permettetele di dire ciò che pensa e di cancellare la metà di quello che ora inserisce, e scriverà un libro migliore uno di questi giorni. Sarà una poetessa, dissi, riponendo L'avventura della vita, di Mary Carmichael, all'estremità dello scaffale, tra cento anni.
poetesse signore, non maschi, vestite da maschi, stronze come i maschi, aggressive come i maschi, competitive come i maschi, sole come i maschi, a letto come i maschi, sterili come i maschi.
cento anni, diceva la Woolf, per diventare poetesse di noi stesse, libere ma DONNE.